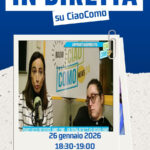Fin dagli anni ’80, l’attenzione del sistema scolastico italiano verso gli alunni con disabilità è stata una priorità, in linea con i principi di inclusione. Negli ultimi 10-15 anni, la sensibilità e le attenzioni sono notevolmente aumentate, estendendosi anche a disturbi e disabilità che, fino a tempi recenti, erano meno diagnosticati o poco riconosciuti.
Problemi come la dislessia, la disgrafia e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) erano, fino a pochi anni fa, spesso sottovalutati o poco diagnosticati.
Oggi le diagnosi di questi disturbi sono salite in modo esponenziale ma allo stesso modo possono essere gestite e quasi eliminate attraverso l’uso di Strumenti Compensativi e Misure Dispensative (come l’uso di tablet, software specifici, o tempi aggiuntivi), individuati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) o nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Questi strumenti possono in molti casi compensare quasi completamente la difficoltà, permettendo all’individuo di esprimersi adeguatamente, raggiungere il successo formativo arrivando in alcuni casi a compensare quasi completamente la difficoltà permettendo così all’individuo di esprimersi adeguatamente nel gruppo.
E’ importante precisare che per attivare questa rete di supporto è necessario avere una certificazione di disabilità specifica, che si ottiene con il normale iter per la richiesta di invalidità.
Sebbene le cronache segnalino spesso una scarsità di insegnanti di sostegno rispetto alle reali necessità, è un dato di fatto che la scuola oggi possa contare su un numero superiore di docenti specializzati rispetto agli ultimi decenni del secolo scorso e che questi godano generalmente di preparazioni specifiche più mirate.
Rispetto alla scuola di 20/30 anni fa circa, gli studenti disabili oggi ricevono molte più attenzioni ed aiuti. Se da un lato questo è un bene, soprattutto per i casi più gravi, non si corre il rischio di stimolare meno gli studenti a sfruttare le loro capacità?
L’eccessiva agevolazione, anche per la paura di “traumatizzare” i bambini (un fenomeno non limitato alla sola disabilità), potrebbe involontariamente renderli più inermi e meno pronti ad affrontare le difficoltà e le frustrazioni che la vita inevitabilmente presenta.
Come le “mancanze” di un tempo potevano spronare alla ricerca di soluzioni, un eccesso di supporti non adeguatamente calibrato rischia di non far emergere appieno il potenziale di auto-superamento dell’individuo.
Oggi il mondo della scuola in generale (non solo per i disabili) cerca di agevolare in molte situazioni i bambini, con la scusa di “non traumatizzarli” ma questo li rende più inermi e meno pronti ad affrontare le difficoltà che la vita, ahimè, ci mette davanti in varie situazioni ed occasioni.
L’assegnazione di strumenti tecnologici, come tablet e altri supporti informatici, agli alunni con DSA o altre difficoltà, è un passo fondamentale.
Senza un adeguato supporto formativo iniziale per imparare a usare gli strumenti e senza programmi di studio davvero personalizzati, l’aiuto rischia di essere riduttivo o solo parziale.
Un percorso di studi adeguato e un sostegno iniziale mirato sono essenziali affinché gli studenti possano gradualmente acquisire la propria indipendenza e sviluppare appieno il loro potenziale di autonomia.
Lo stesso principio vale per gli alunni con difficoltà comportamentali:
Garantire loro un ambiente tranquillo e protetto è necessario per gestire l’emergenza immediata, ma non è sufficiente.
Questo approccio deve essere supportato da un adeguato percorso di sostegno che miri a far superare e gestire i momenti difficili nel contesto della vita quotidiana.
Facendo un esempio concreto, se pensiamo agli alunni con difficoltà comportamentali, il solo garantirgli un ambiente tranquillo e protetto, può aiutarli nell’immediato per poter gestire il momento difficile ma se non supportato da un adeguato sostegno al superamento di questi momenti in modo da imparare a gestirli nell’ambito della vita quotidiana, quando per forza di cose si non si possono avere ambienti protetti e ci si trova soli, in mezzo a persone sconosciute e magari in ambienti estranei.
Facendo una riflessione sull’inverno demografico a cui stiamo assistendo a livello nazionale, sul maggior numero di diagnosi di disabilità e disturbi dell’apprendimento e sul maggior numero di insegnanti di sostegno, forse la difficoltà nel reperirli non è data proprio dall’alto numero di diagnosi?
È plausibile che l’alto numero di nuove diagnosi (e la conseguente richiesta di supporto) stia mettendo sotto pressione la capacità del sistema di formare e assegnare personale specializzato con la stessa rapidità.
La normativa nazionale definisce già aspetti cruciali, come il numero massimo di studenti in una classe in presenza di alunni con disabilità, per garantire una gestione efficace del gruppo.
Il gruppo degli alunni ha il dovere di accogliere attivamente il compagno con disabilità e di adattare l’ambiente e le attività per favorire la sua piena partecipazione.
Allo stesso tempo, l’alunno disabile deve sviluppare la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità per comunicare i suoi bisogni e contribuire attivamente alla vita del gruppo, facilitando così la sua integrazione.
Dalla scuola dovrebbe quindi partire una cultura di abbattimento delle barriere culturali, che sono alla base del pregiudizio e che a volte sono più difficili da superare rispetto alla difficoltà fisiche, pratiche e oggettive.
Solo in questo modo potremo davvero parlare di integrazione.
 Sede di Como
Sede di Como